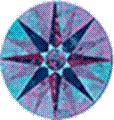1.
Riflessione sulla Disciplina
1.1 Caratteri orientanti della disciplina: analisi epistemica disciplinare
di carattere orientativo
Caratteri che stanno alla base dello statuto
disciplinare, che la costituiscono come disciplina,
Nuclei fondanti, ambiti di intervento, metodologie proprie
La
struttura sia specialistica (accademica) che formativa della Linguistica come
disciplina è davvero complessa. Solo a titolo di schematizzazione il
diagramma seguente evidenzia le aree su cui tale struttura si può articolare.

Il
progetto Per non perdere la bussola
all’interno del “Quadro” ha affrontato
l’analisi disciplinare e ha selezionato alcuni degli aspetti soprastanti, facendo riferimento al Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (2002), che è stato posto al centro
del Progetto, in quanto considerato un documento dal
carattere fortemente orientante. L’approccio “orientato all’azione” tipico del
Quadro ha permesso di rintracciare alcune aree, che sono state oggetto
del Corso di Formazione e che sono fondamento di questa progettazione del
Problem Solving Orientativo, in quanto ritenute più
significative anche dal punto di vista dell’orientamento, non solo
disciplinare, ma formativo in senso lato (educativo), in quanto hanno a che
fare con i processi di comunicazione, che caratterizzano l’uso e
l’apprendimento della lingua, azioni entrambe che possono caratterizzare il
futuro e la sostanza delle scelte di studenti, futuri insegnanti, docenti
esperti.
Le
aree rintracciate sono le seguenti:
1.
la lingua nell’uso: pragmatica, sociolinguistica,
grammatica, analisi testuale (del discorso), neurolinguistica
2.
la lingua nell’apprendimento: glottodidattica
Nuclei
fondanti
I nuclei fondanti[1]
comuni di tutte queste sotto-aree disciplinari, soprattutto se messi in
correlazione col Quadro, possono essere così sintetizzati:
a)
consapevolezza, sia delle caratteristiche della
comunicazione che dei processi di apprendimento e di orientamento
b)
dominio, contesto, situazione
c)
testo
d)
compito
e)
strategia
f)
competenze generali (sapere, saper fare, saper essere e
saper apprendere), linguistico-comunicative (linguistiche, sociolinguistiche,
pragmatiche) e orientative [Pombeni (2000)]
g)
attività linguistiche (ricezione, produzione,
interazione, mediazione)
h)
plurilinguismo
i)
interculturalità
Metodologie
proprie
a)
Orientamento all’azione
b)
Acquisizione (apprendimento implicito) e
apprendimento esplicito delle lingue
c)
Task based learning
d)
Lexical approach
e)
Considerazione attenta delle competenze parziali
1.2 Individuazione di aspetti operativi
Azioni utili a sperimentare contesti
e metodologie disciplinari ovvero strumenti propri della disciplina che ne
definiscono i caratteri metodologici
Il progetto è stato strutturato
come Corso di Formazione e ha quindi una valenza di didattica orientativa, dove
i nuclei fondanti, selezionati all’interno del mare magnum
della linguistica, costituiscono ognuno occasione di operatività.
1.2.1.
Centrale è il testo, inteso come “una sequenza di discorso (orale
e/o scritta), che si riferisce a un dominio specifico
e che, nell’esecuzione di un compito, diventa occasione di attività
linguistica, sia come strumento sia come obiettivo, sia come prodotto sia come
processo” [Quadro (2002), pag. 12]. Se volessimo provare a sostituire
alla dizione “attività linguistica” la parola “orientamento”, avremmo una prova
del carattere orientante di questo importante
documento europeo costituito dal Quadro, considerando anche il fatto
che, per dominio si intende “gli ampi settori della vita sociale in cui
operano gli attori sociali” (Quadro, cit.,
pag. 12). Le principali categorie relative al concetto
di “dominio” rilevate dal Quadro
sono, tra l’altro, le seguenti: educativa, pubblica, personale e professionale.
In altre parole non vi può essere orientamento senza consapevolezza del
dominio in cui si opera e del suo influsso sui processi della comunicazione,
che si attuano in testi, permettendo l’esecuzione di un compito.
* Dal punto di vista operativo, l’intero
progetto è stato fondato sulla testualità, sia scritta che orale, e sulla
comunicazione, sia digitale che analogica. Tutti i docenti, sia universitari
che del liceo, che esterni, hanno basato ogni incontro sull’interazione,
proponendo brevi compiti (task), brainstorming, problemi o attivando modalità dialogiche di comunicazione. Il passaggio al PSO può costituire un momento di approfondimento, fondato
non solo sul lavoro individuale, ma anche su quello di gruppo, del lavoro sul
testo.
Le attività si basano anche nel
PSO sulle capacità cognitive di analisi, percezione, attenzione, applicazione
del noto all’ignoto, generalizzazione, interpolazione, nonché sulla capacità
d’uso di strategie.
1.2.2.
Centrale è pure il concetto di competenze, per come si
manifestano in attività linguistiche e comunicative, aperte all’idea di
life-long learning (e life-wide learning) e quindi di
plurilinguismo (collegato alla nozione di competenze parziali) e di interculturalità.
1.2.3.
Alla pari, sia quanto a valenza formativa che rispetto al peso specifico
che ha trovato all’interno del progetto Per non perdere la bussola all’interno del “Quadro”, si ritrova il concetto di strategia,
che trova il suo ruolo elettivo accanto alle attività di tipo metacognitivo, presenti nel Quadro e poste in relazione al concetto di modificabilità cognitivo-emotiva.
* Dal
punto di vista operativo, molto spazio è stato dato al concetto di competenza
all’interno del progetto, sia dal punto di vista teorico che sotto l’aspetto
pratico. Il concetto di strategia è stato affrontato teoricamente in modo più
limitato, ma dal punto di vista pratico il test A.MI.CO., elaborato e proposto dal prof. Luigi Zanini, esperto di
formazione, ha permesso agli studenti di conoscere direttamente cosa sia una
strategia e come possa essere utilizzata la grande varietà di strategie esistenti.
Collegati al discorso delle competenze sia conoscitive
(“sapere”), che procedurali (“saper fare”), che “esistenziali” (il cosiddetto
“saper essere”) sono i concetti di plurilinguismo e interculturalità,
orientanti in ogni caso verso un mondo lavorativo che prevede inevitabilmente
l’incontro con altre lingue e altre culture. Gli esercizi di tipo
socio-linguistico e pragmatico proposti negli incontri
del progetto hanno dato questo suggerimento agli studenti. Obiettivo
fondamentale è “l’arte dello spostamento dello sguardo” [Zanarini G. (1990)] o
nel lessico di alcuni studiosi dell’orientamento “migliorare
la rappresentazione del problema”, prendendo nello stesso tempo consapevolezza
“delle forma identitarie che gli appartengono” [Guichard, J. e Huteau, M. (2003, ed.it), pag. 12] ed eventualmente distaccandosene, se
considerate “cornici” ostacolanti e limitanti (e se è in grado di farlo).
1.3 Progettazione di un fare quotidiano
Individuazione di contesti
della vita quotidiana in cui le caratteristiche della disciplina possono essere
sperimentate
1.3.1
L’incontro con la diversità culturale: viaggio, immigrazione, lettura
(narrativa e saggistica)
1.3.2
L’incontro con la diversità sociale: economica, di genere, di contesto e di situazione…
1.4 Modalità di
approccio ai problemi
Teorico, sperimentale o equivalenti
Si specificano di
seguito le diverse tipologie di approccio adottate
all’interno dell’intero progetto, anche nella fase preparatoria pre-estiva, ma tipiche comunque della didattica, non solo
delle lingue straniere. Si tratta quindi più di glottodidattica,
in questo settore specifico, che come visto è un aspetto della Linguistica
applicata all’insegnamento/apprendimento delle lingue.
1.4.1
Approccio trasversale
1.4.2
Approccio inter-culturale e plurilinguismo
1.4.3
Approccio metacognitivo,
fondato sul concetto di Modificabilità cognitivo-emotiva
1.4.4
Approccio sia esplicito che implicito
all’insegnamento/apprendimento e sua consapevolezza
1.4.5
Approccio umanistico: problem solving,
brainstorming, interazione, relazione, attenzione alle emozioni, saper essere
1.4.6
Valutazione del processo: questionari, diari,
ricerca/azione
1.4.7
Modalità di autovalutazione
delle competenze
1.4.8
Portfolio
1.5 Contenuti metodologico-formativi della
disciplina
Che possano essere riferimento per la scelta degli esercizi
1.5.1
Testi scritti letterari: Il viaggio e i
viaggiatori (la letteratura come strumento di riflessione ha accompagnato ogni
incontro del Corso, con un brano collegato all’argomento del corso e commentato
in modo interattivo)
1.5.2
Testi autentici: brani di conversazione
1.5.3
Testi della pubblicità
1.5.4
Studio della grammatica, e confronto tra le modalità esplicite – dichiarative (metodo grammaticale
logico-deduttivo), e quelle implicite – procedurali – orientate all’azione
(metodo comunicativo, tipico dello studio delle lingue moderne)
1.5.5
Interculturalità e consapevolezza dei
meccanismi identitari.
2.
Predisposizione dell’Attività
2.1 Numero e caratteristiche dei quesiti
I quesiti sono quattro, tutti tratti da: Yule, George (nuova ed.it. 1997), Introduzione alla linguistica, il
Mulino, Bologna. Sono state in parte modificati, per
renderli di difficoltà più o meno equivalente. I problemi sono tutti accomunati
dalla presenza di una lingua che non appartiene al ceppo europeo, in quanto questo lavoro risulta implicitamente formativo
verso l’apertura alla diversità linguistico-culturale,
riconosciuta in questo caso sulla base di identiche necessità comunicative,
come esprimere l’idea di possesso, di tempo, di persona, di plurale e singolare…
2.1.1
Sulla grammatica e le sue connessioni interculturali
2.1.2
Sulla pragmatica e sulla sociolinguistica
2.2 Modalità di
scelta dei quesiti da parte degli studenti
2.2.1
Proiezione dei problemi sullo schermo
2.2.2
Scelta per alzata di mano (al massimo 4
studenti per grupppo e al massimo 3 gruppi per ogni problema)
2.3
Modalità organizzative
2.3.1
Studenti
-
Si coinvolgono solo gli studenti che sono
interessati ad approfondire in chiave orientativa disciplinare le questioni
emerse dal corso, in quanto si sentono attirati a
qualsiasi titolo dalle implicazioni della Linguistica
-
Si coinvolgono studenti delle quarte e delle
quinte, anche non iscritti, che possono anche fungere da gruppo parallelo per
comparazione dei risultati
-
Si stende un elenco dei partecipanti (che
fungerà anche da elenco per le firme)
-
Vengono predisposte etichette
e si chiede ad ogni gruppo di darsi un nome, che va segnato sull’etichetta,
insieme al nominativo dello studente
2.3.2
Collaborazione con i corsisti SSIS che, per Lettere,
seguono un regolare percorso di tirocinio per l’orientamento, strutturato e con
accesso a crediti.
-
Scelta del quesito e abbinamento dei
tirocinanti ai gruppi di studenti (uno o due tirocinanti per gruppo)
-
Studio della progettazione del
PSO da parte dei corsisti SSIS (a casa)
-
Soluzione del quesito prescelto (a casa)
-
Partecipazione all’attività assembleare
del PSO, con osservazione dei gruppi e relazione finale
2.3.3
Viene predisposto un calendario
di massima, che viene proposto e discusso insieme agli studenti del liceo
Marinelli e ai corsisti della SSIS il 2 novembre 2006
2.3.4
CALENDARIO
-
Un incontro di 2 ore (prime due fasi del PSO: individuale e di gruppo) - 9 novembre pomeriggio
(in contemporanea con il recupero del test A.MI.CO)
-
Sull’ambiente web
i.
(terza fase PSO): scrittura collaborativa (una
per ogni gruppo, con l’intervento del tirocinante) – stesura di un rapporto di
sintesi dei risultati e di interpretazione delle
procedure di soluzione - tempo: due settimane
ii.
(quarta fase PSO): forum – discussione sui
problemi, sulle strategie usate per la soluzione, sulle scoperte fatte, sulle connessioni
della tematica del problema con le conoscenze e
competenze tratte dal corso, sull’interesse sollevato dalle problematiche – con
intervento del tirocinante SSIS
-
Secondo incontro di 2 ore - Proposta: 23
novembre (14.00-16.00)
i.
(quinta fase PSO) Discussione sui vari testi
risultanti dalla scrittura collaborativa sul web e su alcune delle questioni
aperte dal forum, con partecipazione da parte dei tirocinanti SSIS
ii.
(sesta fase PSO) Stesura individuale di un rapporto
libero sull’esperienza, con osservazione da parte dei tirocinanti SSIS
iii.
Questionario finale
3.
Documento cartaceo da consegnare agli Studenti